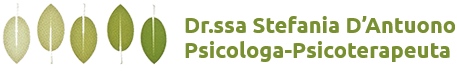Film & books
Film
La metamorfosi di un narcisista: "Ricomincio da capo" di Harold Ramis

“Ricomincio da Capo” è una commedia del 1993 diretta da Harold Ramis e interpretata da Bill Murray e Andie McDowell.
Il film narra le vicende di un uomo, un metereologo di nome Phil, costretto da uno scherzo del destino a rivivere lo stesso giorno all’infinito. Nel film non viene svelato come mai il protagonista rimane imprigionato in una sorta di “incantesimo” che lo condanna a vivere e rivivere la gelida giornata del 2 febbraio in una cittadina della Pennsylvania dove si festeggia il tradizionale e folcloristico “Giorno della Marmotta”.
Credo che la spiegazione vada ricercata nella situazione esistenziale del personaggio: Phil è un narcisista, imprigionato nell’amore per se stesso, in un eterno inverno dei sentimenti.
Nel corso del film, abbiamo la possibilità di seguire il protagonista nei vari tentativi che mette in atto per affrontare e risolvere questo suo problema. La psicologia di Phil conosce una profonda e sofferta metamorfosi: egli da egocentrico, spocchioso, superbo e insoddisfatto di sé, degli altri e della vita diventa generoso, sensibile e attento ai bisogni degli altri, riuscendo a ridimensionare notevolmente l’idea “grandiosa” che aveva di se stesso.
All’inizio il film mostra un metereologo di successo che conduce programmi di previsioni del tempo, il quale viene inviato come ogni anno nella remota cittadina di Punxsutawney per realizzare un servizio televisivo sul “Giorno della Marmotta”. Phil è palesemente infastidito da ciò, l’idea di recarsi nuovamente in questa sperduta cittadina innevata a testimoniare di una marmotta che uscendo dalla sua tana è in grado di prevedere una precoce primavera o al contrario un prolungarsi dell’inverno per altre sei settimane lo irrita profondamente; si intuisce che Phil si sente superiore a questo tipo di compiti, probabilmente non si sente sufficientemente valorizzato dalla rete televisiva per la quale lavora (tanto che lo si vede meditare di licenziarsi) e per reazione non fa altro che disseminare intorno a sé malumore e disprezzo sulla gente, sul posto, rendendo difficile il lavoro a se stesso e ai suoi compagni di viaggio, l’ispettrice di produzione Rita (interpretata da Andie McDowell) e il cameramen, i quali di Phil hanno una precisa e poco lusinghiera opinione: un “narcisista egocentrico”, una “primadonna”.
Il primo giorno di quella che si rivelerà per Phil una strana, interminabile villeggiatura passa per lui in modo frustrante e sgradevole: sveglia alle 6, sulle note di “I got you babe” di Sonny e Cher, accompagnato dalle voci allegre di due DJ che preannunciano la grande festa, strade ricolme di gente eccitata, incontro non gradito con un ex compagno di scuola, realizzazione del servizio televisivo in cui l’evento tradizionale tanto atteso viene liquidato da Phil con toni sarcastici e irrisori (la marmotta, tra l’altro, si chiama Phil come lui), tentativo di fuga dalla cittadina interrotto da una tormenta di neve.
Giorno dopo giorno, Phil si sveglia con lo stesso brano musicale, incontra le stesse persone del giorno prima, assiste agli stessi dialoghi, in una ripetitività che assume i contorni di una solitudine alienante e disperata.
Phil tenta varie strade per uscire dalla trappola: in un primo momento, cerca di sfruttare la situazione a suo favore, soprattutto per conoscere e conquistare delle donne; inoltre, si comporta come se non avesse nulla da perdere e dunque si lascia andare infrangendo la legge in vari modi, potendo contare su una sorta di immunità che l’incantesimo gli garantisce. Ben presto però insorge la depressione e Phil tenterà il suicidio, anche in questo caso, senza conseguenze di rilievo. Il giorno dopo si risveglierà, come se nulla fosse accaduto, sulle familiari note di “I got you babe”.
In preda al vittimismo e alla disperazione, Phil chiede aiuto ad uno psicologo, denigrando anche lui (“Ha seguito corsi di psicologia veterinaria?”) e a Rita, verso la quale comincia a sviluppare un certo interesse e attaccamento.
Ella nulla può fare per aiutarlo, se non stimolarlo – con la sua gentilezza e pazienza – ad allargare il suo campo visivo, uscire dalla “tana” dell’egocentrismo e dedicare parte delle sue attenzioni ed energie anche agli altri.
Dopo una notte passata con Rita, la quale mette a sua disposizione tutta la sua dolcezza e accoglienza per sostenerlo nella crisi – succede qualcosa nella vita di Phil, in modo impercettibile ma magico: Phil esce per l’ennesima volta dall’albergo dove soggiorna, dopo aver rivolto parole insolitamente gentili ai gestori, e quando – come ogni giorno – passa accanto al mendicante, per la prima volta gli lascia del denaro; abbraccia l’ex compagno di scuola, precedentemente trattato con fastidio e disprezzo; si presenta su set con la colazione per i suoi due colleghi, che rimangono visibilmente sorpresi: Phil non è solito a questo tipo di attenzioni.
Dopo aver registrato il servizio, Phil comincia una giornata nuova in cui si dedica agli altri, aiuta il clochard, sventa un incidente, parla con le persone non più per un proprio tornaconto ma per sperimentare un nuovo tipo di contatto più profondo con gli altri, un tipo di relazione in cui non esistono più solo i propri bisogni ma anche quelli degli altri. Tutto questo gli provoca emozioni, anche dolorose: il clochard muore tra le sue braccia, nonostante tutti i suoi tentativi di tenerlo in vita. Ma Phil non si limita a dedicarsi agli altri, dedica delle energie anche per coltivare nuovi talenti: va a lezione di pianoforte, impara a scolpire il ghiaccio…. E nel fare tutto questo, lentamente, diventa una persona migliore e i giorni non sono più uguali gli uni agli altri. Egli riesce a trarre da quell’unico giorno a sua disposizione il meglio per se stesso. Impara ad amare e rispettare di più se stesso e conseguentemente anche gli altri. Si prende pienamente la responsabilità della sua vita e getta le basi per un graduale ma inesorabile scongelamento dei suoi affetti.
Non solo le relazioni con gli altri, ma anche la sua professione trae benefici da questo suo cambiamento: il servizio sul “Giorno della Marmotta” diventa un prodotto di qualità, assume toni filosofici, quasi poetici in cui l’inverno – stagione in cui la marmotta Phil esita a rimanere con delicato timore – diventa la metafora eccezionalmente fertile di una soglia da attraversare, di una fase del ciclo di vita della natura e dunque anche dell’essere umano densa di significati, preludio di un rinnovamento.
Quell’eterno ripetersi di una fredda giornata di febbraio altro non è che la metafora dell’inverno dei sentimenti in cui viveva il protagonista, una prigione che lo condannava alla solitudine. Come la marmotta sua omonima, Phil viveva rintanato in un piccolo mondo in cui gli altri non esistevano e, come la marmotta, uscito dalla tana doveva capire se era arrivato il momento di una primavera dei sentimenti o se, spaventato dalla propria ombra, rimanere rintanato nell’inverno un altro po’.
Il passaggio ad una nuova stagione, più dolce e tiepida, avviene. Phil si innamora di Rita sinceramente e autenticamente, non più per bisogno di conquiste e conferme; è gentile con gli altri non per ricevere ammirazione ma perché lui sta meglio così con se stesso. Impara ad amare gli altri in modo disinteressato, non più autoreferenziale.
Il momento è propizio per l’arrivo nel suo cuore della primavera. Una sera la sua amata lo “acquista” per gioco ad un’asta di beneficienza e il giorno dopo Phil si risveglia tra le sue braccia: è il 3 febbraio. Finalmente.
Le bugie dei figli ai genitori: "Buffalo 66" di Vincent Gallo

Quando i figli non hanno il coraggio di assumere su di sé la responsabilità di non essere il “figlio perfetto”, di non aderire perfettamente alle aspettative dei genitori, può succedere che tentino di colmare questo “scollamento” dall’ideale del sè, questa “mancanza” con le bugie.
Modellano il loro essere sulla base di ciò che pensano che i loro genitori desiderino da loro. Invece di essere se stessi, partono all’inseguimento dei desiderata genitoriali e mentono un po’ su tutto: sui voti che prendono a scuola, sulla loro situazione amicale o sentimentale, sulle loro idee, sui loro reali bisogni.
Tutti i bambini hanno questa tendenza, in quanto durante i primi passi, anni della loro esistenza, essendo ancora molto dipendenti da colui o coloro che si occupano di loro, essi fanno le cose soprattutto per vedere gli occhi dei genitori brillare di felicità e soddisfazione. D’altra parte, è opportuno sottolineare che una giusta dose di conferme e approvazione altrui è fondamentale per uno sviluppo armonioso della personalità e dell’autostima.
Pian piano il genitore dovrebbe però riuscire a trasmettere al figlio la sensazione che l’amore che lo lega al figlio è INCONDIZIONATO: non è influenzato dalle prestazioni (scolastiche, sportive) cioè dai successi o fallimenti del figlio. Non dipende dai gusti personali, dai talenti manifestati, dalle opinioni del figlio.
Il genitore dovrebbe riuscire a spronare il figlio a essere se stesso e a comunicargli la totale accettazione del figlio come essere umano. Ovviamente questo non vuol dire che un genitore non debba intervenire disapprovando un dato comportamento negativo del figlio; egli però dovrà fare molta attenzione che il figlio percepisca che la disapprovazione è rivolta al comportamento non al figlio come persona. Sarà utile distinguere i giudizi sui comportamenti da quelli sulla persona, utilizzando frasi come: “Quello che hai fatto non va bene, non è giusto, non è corretto; quello che hai fatto mi è dispiaciuto….” piuttosto che frasi come: “Sei un bambino cattivo, scorretto, mi fai impazzire, disperare etc…”.
Non è facile, soprattutto quando il figlio viene visto dal genitore come la possibilità di superare attraverso le sue prestazioni le proprie manchevolezze, i propri limiti, le proprie insoddisfazioni. “Io non ho potuto studiare, vorrei che mio figlio lo facesse”; “Io non avevo amici ed ero timido, vorrei che mio figlio non lo fosse” oppure “Io ero arrendevole e fifone, vorrei che mio figlio fosse coraggioso e propositivo”.
Anche se questi desideri (naturalmente rivolti al benessere dei figli) non vengono chiaramente espressi a parole, traspaiono dagli atteggiamenti, dai consigli che un genitore dà nel quotidiano al proprio figlio. Quanto più un genitore non si realizza con le proprie forze sviluppando e coltivando le proprie risorse e – a volte credendo poco in se stesso, a volte non accettando i propri fallimenti – chiede al figlio di arrivare dove egli non è riuscito ad arrivare, tanto più il figlio sarà imprigionato nella vita del genitore, assumendo su di sé il compito di riparare le sue ferite.
Dedicare la propria vita ad esaudire i desideri e le aspettative dei genitori può in certi casi allontanare un figlio da se stesso. Inseguire ciò che gli altri vogliono da me può diventare più importante di ciò che io sono e desidero veramente. E quanto più un genitore è visto fragile, incapace di accettare la frustrazione può emergere da parte del figlio, come strategia di sopravvivenza, la tendenza a mentire, a trasformare la realtà in funzione dei bisogni dei genitori. Le bugie si accumulano le une sulle altre e, per coprirle, bisogna inventare altre bugie, allontanandosi sempre più dalla possibilità di uscire dal gioco infernale.
Un caso estremo di queste dinamiche è la storia di Billy Brown, descritta nel tragicomico film del 1998 “Buffalo ‘66” diretto e interpretato da Vincent Gallo.
Incapace di mostrarsi ai genitori per quello che è veramente, non essendosi sentito mai accolto con empatia nel rapporto con i genitori, Billy copre i suoi fallimenti con bugie neanche troppo credibili a cui i suoi genitori fanno finta di credere, in un trionfo di falsità, di mancanza di autenticità. Ciò che colpisce nel ritratto relazionale come un pugno nello stomaco è il fallimento dell’esperienza dell’intimità in questa famiglia, in cui ognuno è chiuso nel suo mondo artefatto, nei suoi stati d’animo, incapace di comunicarli agli altri.
Billy, appena uscito dal carcere, in procinto di andare a trovare i suoi genitori che non vede da cinque anni, si inventa al loro cospetto una vita inesistente fatta di successi lavorativi ma soprattutto d’amore, chiedendo ad una dolcissima ragazza (che si intuisce essere sola quanto lui) di reggergli il gioco facendo finta di essere sua moglie.
L’incontro con i genitori è struggente, non solo per la reciproca finzione, ma anche perché i genitori si mostrano più accoglienti verso l’estranea che verso il loro figlio. Tutti i loro gesti, tutte le parole manifestano rifiuto verso questo figlio e l’impressione è che le bugie li allontanino sempre più dalla possibilità di un riconoscimento reciproco profondo.
E’ la relazione “alla pari” con la ragazza, l’unica con cui Billy riesce a mostrarsi per quello che lui è davvero (con l’amico “Tonto”, con cui Billy è altrettanto sincero, la relazione è troppo asimmetrica, priva di una vera intimità), che lo aiuterà ad abbandonare i suoi folli progetti autodistruttivi di vendetta e a cominciare una nuova vita.
La relazione di cura nel film: “Lars e una ragazza tutta sua” di Craig Gillespie

Nel film “Lars e una ragazza tutta sua”, diretto nel 2007 da Craig Gillespie, il fragile e tenero protagonista, segnato da un trauma devastante – la mamma è morta dandolo alla luce – non riesce ad instaurare relazioni affettive significative e conduce una vita abitudinaria e isolata, dividendosi tra casa, ufficio, chiesa.
Lars abita in un piccolo paesino della provincia americana, non ha amici, non ha mai avuto una fidanzata; ha un fratello – sposato – con il quale rifiuta persino di fare colazione o qualsiasi altra cosa insieme. Vive in un prefabbricato vicino alla casa paterna (che Lars ha lasciato al fratello Gus e alla moglie Karin) che, quando il padre era in vita, era adibito a garage.
La moglie del fratello rimane incinta e, dopo poco tempo, Lars ordina via internet una real doll, una sorta di “bambola” del tutto simile ad una donna che presenterà a tutti come la sua fidanzata, Bianca, una missionaria in sedia a rotelle. Gus e Karin, sconvolti, preoccupati che Lars sia impazzito del tutto (lo hanno sempre considerato un tipo un po’ strambo), portano Lars e Bianca dalla dottoressa del paese che non solo è medico ma anche psicologa, la quale prende in cura Lars e quella sorta di oggetto transizionale che è Bianca.
La dott.ssa Bergman, nell’invitare Gus e Karin ad accettare Bianca tra loro e ad assecondare il tentativo di Lars di costruirsi un mondo parallelo, fa ciò che Luigi Cancrini, psichiatra e psicoterapeuta sistemico, nel libro “La psicoterapia: grammatica e sintassi” definisce “rispetto delle ragioni profonde” che sostengono i comportamenti sintomatici; ma la dottoressa spinge il suo paziente anche ad esplorare nuove espressioni di sé, nuovi ruoli. Ed è nella relazione intensa, terapeutica con la dott.ssa Bergman che Lars si fa toccare per la prima volta in vita sua emotivamente e fisicamente, comincia a spogliarsi degli strati di abiti indossati a cipolla l’uno sull’altro per rimanere perfettamente isolato dal mondo e dalle persone che lo abitano, comincia a dar voce alle sue paure rimaste incapsulate (come per un incantesimo che ha fatto fermare le lancette del tempo) per tanti anni e che hanno cominciato a farsi sentire nel momento in cui sua cognata è rimasta incinta: la gravidanza è pericolosa perché si conclude con un parto, che nel caso di sua madre è stato fatale!
Per mezzo di Bianca, il sintomo, Lars comincia a frequentare la casa del fratello, a relazionarsi con la comunità, ad aprire il suo cuore e ad affidarsi alle cure di un Altro significativo, la sua terapeuta, con la quale condivide il suo trauma ed impara l’empatia, preziosa facoltà fondamentale per stabilire relazioni soddisfacenti in cui sia possibile comprendersi l’un l’altro, darsi reciproco conforto e accoglimento.
Alla fine Lars, avendo imparato la non necessità del sintomo, distruggerà con grande dolore e rabbia Bianca, per andare incontro a relazioni con persone vere… amici, vicini di casa, colleghi, conoscenti, una ragazza innamoratasi di lui… che gli sono stati vicini nel periodo della malattia rigeneratrice.
Libri
Alcune considerazioni su genitorialità, educazione e soddisfacimento dei bisogni dei figli: “La fabbrica di cioccolato” di R.Dahl.
“Charlie and the Chocolate Factory” è il celebre libro scritto da Roald Dahl nel 1964 – da cui sono stati tratti anche due fortunati adattamenti cinematografici – la cui magia consiste nel diventare sempre più attuale man mano che passano gli anni: è un libro che parla a grandi e piccini di tutte le epoche e contesti socio-culturali.
La trama è nota: Willy Wonka, il proprietario di una fabbrica di cioccolato, decide di mettere in palio cinque biglietti d’oro (nascosti in tavolette di cioccolato) che permetteranno ai cinque fortunati bambini che li troveranno di fare una visita nella sua fabbrica e di vincere un premio speciale.
La visita alla fabbrica si rivela in realtà un percorso disseminato da prove che i bambini devono superare, facendo i conti con i propri punti deboli e le proprie risorse per arrivare al traguardo. Il signor Wonka, infatti, sta cercando un degno erede, un bambino buono e leale a cui trasmettere (come un padre a un figlio) le esperienze e il sapere legati al suo lavoro di cioccolatiere, ma soprattutto l’amore per la sua creatura, la Fabbrica.
Senza mezzi termini e con scoppiettante umorismo, Dahl costella il suo racconto di riflessioni pedagogiche sull’infanzia e il rapporto genitori-figli: le conseguenze della difficoltà dei genitori nel mettere i limiti ai figli; le conseguenze dell’uso smodato della televisione e in senso più ampio della tecnologia; il fenomeno sempre più diffuso dei bambini tirannici a casa e incapaci farsi valere fuori; quali sono i valori che davvero possono aiutare i figli a farsi strada nella vita e avere successo.
Questi sono i cinque bambini che trovano il biglietto d’oro:
Augustus Gloop: goloso, ingordo, cicciottello, incapace di mettere dei limiti al quantitativo di cibo che ingurgita e incapace di gustarlo davvero, in quanto gli manca l’esperienza della privazione e del desiderio. Spiega la mamma, orgogliosa, sovrappeso anche lei, e con ogni probabilità iperprotettiva: “Mangiare è il suo unico hobby. È l’unica cosa che gli interessi […] Comunque è sempre meglio che andare in giro a fare il teppistello e a sparare con le pistole spaziali nel tempo libero, non vi pare?”.
Veruca Salt: figlia di buona famiglia, viziata, tirannica, perennemente insoddisfatta e oltremodo richiestiva nei confronti di genitori che, saccenti e snob, paiono aver rinunciato alla loro funzione educativa (verranno infatti espulsi dal gioco e puniti anche loro), concedendole tutto ciò che chiede. Come nel caso di Augustus, la sua rovina sarà proprio l’ingordigia, non di dolciumi ma di oggetti-feticcio usa e getta, che perdono ogni attrattiva una volta posseduti.
Violetta Beauregarde: afflitta da “gommite acuta”, campionessa di masticazione di chewing-gum, un concentrato di maleducazione (parla masticando gomme e quando si stufa le attacca sui pulsanti dell’ascensore per fare i dispetti alle signore con i guanti che vivono nel suo palazzo), competitività e impulsività male arginato da due genitori incapaci di farsi rispettare. Ignorando gli ammonimenti degli adulti in genere, come se – dall’alto dei suoi dieci anni – potesse già farne a meno, Violetta afferrerà una gomma triplo gusto “Wonka” in via di sperimentazione e si trasformerà in un gigantesco mirtillo viola.
Mike Tivù: video-dipendente, tristemente destinato ad un futuro da schizoide, a meno che non succeda qualcosa nella sua vita che gli offra l’opportunità di rompere il guscio in cui vive. Mike infatti è completamente isolato nella sua realtà parallela fatta di “telefilm sui gangster”, imbottiti di piombo e violenza. Anche lui riceverà una bella lezione, come gli altri per contrappasso, per mezzo della sua morbosa attrazione per il tubo catodico. C’è da augurarsi che impari qualcosa di utile per migliorare la sua esistenza.
Infine, Charlie Bucket: il protagonista, il vincitore del premio speciale. Un bambino proveniente da una famiglia povera di beni materiali ma ricca di affettività, in cui ha potuto fare esperienza del limite, della privazione, della rinuncia, diventando più consapevole dei suoi limiti e resiliente degli altri concorrenti. Un bambino che, attraverso la privazione, si è costruito la capacità del saper desiderare e impegnarsi in prima persona, utilizzando tutte le risorse a propria disposizione, per raggiungere i suoi obiettivi.
Quando, nel corso della visita, un concorrente viene espulso dal gioco, gli Umpa-Lumpa, operai che lavorano nella fabbrica, gli dedicano una canzoncina che spiega i motivi dell’esclusione.
Sono versi ricchi di sarcasmo e, nell’intenzione dell’autore, portatori di un messaggio educativo.
Questi versi sono tratti dalla canzoncina dedicata ad Augustus, il quale dopo essersi sporto imprudentemente in un fiume di cioccolato fuso viene risucchiato in un tubo che trasporta il cioccolato nei vari reparti della fabbrica:
“Augustus Gloop! Augustus Gloop dentro il fiume hai fatto ploop!
Mangi e bevi a sazietà, ma non ti nutri di bontà!
Sei stato sempre un gran porcello, senza mai dare niente di bello.
Che fare a tipi come te? […]
L’unica buona soluzione si trova nella tubazione!
Certamente uscirà cambiato da questo tubo nel quale è entrato”
Anche verso Violetta gli Umpa-Lumpa esprimono un giudizio piuttosto severo:
“E’ certo che la vita, amici cari, di spettacoli immondi ne offre vari,
ma uno dei più brutti e rivoltanti […] è quello offerto da quei derelitti che da gommite acuta sono afflitti.
[…] Son quasi peggio di chi si va a cacciare un dito dentro al naso.
Che brutto vizio, che brutta cosa ruminare la gomma appiccicosa!
Chi mastica cicche o fuma sigarette prima o poi, è sicuro, ci rimette. […]
È per questo che abbiamo provato a salvare Violetta da un tal fato.
È ancora giovane. Può ancora cambiare e smettere il continuo masticare.”
Veruca riceve un trattamento esemplare: finisce nello scarico dell’immondizia per aver preteso a tutti i costi che il papà le comprasse uno degli scoiattoli addetti a sgusciare le noci per conto del signor Wonka, seguita da lì a poco dai suoi genitori. Gli Umpa-Lumpa si scatenano:
“Veruca Salt! Veruca Salt! bambina viziata, giù per lo scarico è stata gettata!
[…] Lungo la strada, tra l’immondizia, avrà occasione di fare amicizia con personaggi interessanti,
anche se proprio non tanto eleganti quanto quelli a cui è abituata. […]
A queste Veruca si va ad abituare perché tale è il prezzo che deve pagare
per essere stata così prepotente senza curarsi mai della gente.
Ma ora, miei cari, se un po’ riflettete una domanda di certo farete:
possibile che ogni responsabilità tocchi a Veruca senza fare a metà con chi deve averla in fondo aiutata,
perché è ben vero che è stata viziata ma, come dice la stessa parola, non si poteva viziare da sola!
Chi tutte vinte sempre le dava e in tutto e per tutto l’accontentava?
Chi l’avrà resa così smorfiosa, impertinente, egoista e noiosa?
Chi sono i colpevoli, i malfattori? Ahiahi! Ma è ovvio: i genitori!
Cosa ben triste ma, almeno a metà, la colpa è anche di mamma e papà!
E così è giusto che siano caduti giù per lo scarico insieme ai rifiuti!”
La canzoncina dedicata a Mike, che si teletrasmette diventando minuscolo, diventa l’occasione per criticare il cattivo uso della televisione (dei videogiochi, del Network, delle nuove tecnologie) che, da strumento di per sé utile, rischia di diventare dannoso se utilizzato senza limiti e discernimento, ma soprattutto in contesti in cui i genitori non sono presenti:
“Perché un bambino sia bene educato una cosa importante abbiamo imparato:
non permettete mai e poi MAI, onde evitare un sacco di guai,
che il miserello se ne stia fermo davanti a un qualche teleschermo.
Anzi, il consiglio più pertinente sarebbe non istallare per niente
Questi apparecchi che rendon cretini sia i più grandi che i più piccini.
In tutte le case che abbiam visitato c’era un bambino seduto impalato,
lo sguardo lustro, la bava alla bocca, davanti a una buffa scatola sciocca.
Taluni possono stare per ore muti guardando il televisore. […]
Seduti immobili, ipnotizzati, come ubriachi paralizzati
Con il cervello tele lavato in un massiccio tele bucato.
È vero, signora, che tiene buoni anche i bambini più birbaccioni,
che così noie più non le danno e fuori dai piedi un po’ se ne stanno
mentre lei scola e condisce la pasta o con le amiche gioca a canasta –
ma non si è mai fermata a pensare a tutti i danni che può causare
una massiccia esposizione ai raggi della televisione?
FA A TUTTI I SENSI L’ANESTESIA, UCCIDE TUTTA LA FANTASIA!
RIEMPIE LA MENTE DI PACCOTTIGLIA E FA VENIRE GLI OCCHI DA TRIGLIA!
RENDE PASSIVI E CREDULONI, ALLENTA IN BLOCCO ROTELLE E BULLONI
CHE IL CERVELLO FAN FUNZIONARE, NON LASCIA PIU’ NULLA DA IMMAGINARE,
IL GUSTO PER LE FIABE ROVINA, TUTTA LA TESTA RIDUCE IN PAPPINA!
A questo punto qualcuno dirà: “Va bene, va bene, ma come si fa?
Se questo mostro di cui parlate va eliminato con due pedate,
come faranno i nostri figlioli a divertirsi, specie se soli?
Come passare una bella serata senza la tele illuminata?”
Scordato avete la vostra storia? Vi rinfreschiamo un po’ la memoria?
C’era una volta una grande avventura: la consuetudine alla lettura!
Pieni di libri i comodini, scaffali, tavoli e anche lettini!
Tutti leggevano e il tempo volava, e con il tempo la mente viaggiava:
storie di draghi, regine e pirati, di navi e tesori ben sotterrati;
deserti, giungle e fitte foreste, cannibali e indios a caccia di teste.
Paesi strani e luoghi mai visti, malvagi, eroi, tipi buffi o tristi: di spazio per i sogni ce n’era a iosa,
leggere era un’attività meravigliosa!”
Personalmente quello che ho più apprezzato leggendo il libro è la schiettezza e il coraggio con cui Dahl affronta certe tematiche tanto universali quanto scomode. Anche se il modo in cui tratta i bambini che vengono esclusi dal gioco potrebbe sembrare a tratti “crudele”, in realtà si percepisce, tra le righe, anche della simpatia e comprensione per loro. Dahl sembra voler dire che in ogni bambino (e adulto) c’è un po’ di Augustus, Veruca, Violetta e Mike… l’importante è esserne consapevoli e aiutare queste parti bambine a crescere.
Il tema di fondo di questa storia, per come l’ho letta io, è il rapporto che le persone instaurano con gli oggetti. Mi riferisco, in particolare, a quel particolare attaccamento che si può instaurare, soprattutto in tenera età, verso oggetti (cibo, giocattoli, TV) o abitudini (ciucciare un pezzo di stoffa o un succhiotto, attorcigliarsi i capelli), che io chiamerei “sostituti materni”, in quanto acquisiscono – nei momenti di stress – il significato di equivalenti delle cure che si possono ricevere da un adulto di riferimento che svolge una “funzione materna” (uomo o donna che sia). C’è da sottolineare che proprio il cioccolato è l’oggetto consolatorio per antonomasia, in quanto stimola in chi lo mangia la produzione di endorfine, sostanze alla base della percezione del piacere.
Compensare con un oggetto un affetto mancante può essere non solo necessario ma indispensabile per affrontare un’assenza senza sprofondare nell’angoscia. Permette ai bambini di padroneggiare la tristezza legata alla perdita del caregiver, ma anche agli adulti di sopportare la separazione dalla persona amata (fidanzati, amici, figli). È un modo funzionale e adattivo con cui ci si consola, nella dolorosa attesa della riunione.
Focalizzando il discorso sull’infanzia, è opportuno sottolineare che, in alcune situazioni, anche dopo la riunione con il caregiver, il bambino continua a percepire un’assenza. È il caso di quei bambini che si riuniscono con genitori stressati e distratti, col pensiero costantemente da un’altra parte, impegnati in altri compiti evolutivi o questioni esistenziali: problemi lavorativi, depressione, elaborazione del lutto, legame irrisolto con la famiglia d’origine. Spesso sono i genitori stessi a proporre al bambino un “sostituto materno”, un oggetto che possa fare da surrogato alla loro presenza, o che possa distrarlo dall’adulto, disincentivando nel bambino richieste d’attenzione: pensiamo al genitore super impegnato col lavoro, che passa molto tempo in ufficio e arriva a casa la sera stremato, e ricopre il figlio di giocattoli, con l’intenzione più o meno conscia di risarcire il figlio dalle molte ore passate da solo. Pensiamo a quel genitore ancora molto coinvolto nella famiglia d’origine, dove magari ricopriva un ruolo di “parental child”, impegnato quindi su due fronti familiari, che concede spesso e volentieri al figlio di passare il suo tempo davanti ai videogiochi, in modo da riuscire a ritagliarsi del tempo per fare un’importante telefonata con cui cercherà di convincere il suo anziano padre che non ne vuol proprio sapere a rivolgersi agli Alcolisti Anonimi per smettere di bere; o con cui cercherà di far riappacificare due membri della famiglia d’origine dopo un litigio scoppiato a causa di un malinteso; o con cui farà un po’ di compagnia alla madre, inconsolabile vedova.
Quale oggetto potrà mai sostituire nella vita di un bambino la presenza affettiva di un genitore poco disponibile?
Il bambino, se questa situazione è cronica, non potrà mai abbandonarsi totalmente ai genitori e vivere fino in fondo la sua dipendenza da loro: è questa la via maestra per diventare autonomi. Dovrà fare affidamento a dei sostituti materiali che consoleranno al momento, ma con cui non sarà possibile compiere in modo pieno e soddisfacente il percorso che porta dalla dipendenza affettiva all’autonomia, alla capacità cioè di prendersi cura di se stessi in modo autonomo, facendo da genitori a se stessi. Anche da adulto, cercherà gratificazioni nel cibo, nel fumo, nelle sostanze stupefacenti, negli acquisti compulsivi, nel gioco d’azzardo.
Spesso i genitori che cercano di riempire i vuoti dei figli con degli oggetti non solo hanno ricevuto lo stesso trattamento dai loro genitori, ma cronicamente tendono essi stessi a confondere oggetti e persone: cercano negli oggetti gratificazioni, sicurezza, piacere… senza mai trovarli. La ricerca diventa infinita e compulsiva perché il desiderio sottostante, il desiderio coperto e non riconosciuto, è un desiderio di altro, il desiderio d’amore.
Quando si cerca di compensare cronicamente l’assenza di un affetto con un oggetto, un qualcosa di natura immateriale con un bene materiale, tendono a svilupparsi dellee dipendenze. Si impara a rivolgersi sistematicamente ad un oggetto in quei particolari contesti affettivamente deprivanti in cui un bene materiale viene percepito più affidabile di una figura di attaccamento: l’oggetto non tradisce, non sparisce all’improvviso, non mostra comportamenti rifiutanti, è sempre lì, a totale disposizione. Se si rompe o si rovina può essere facilmente sostituito.
Charlie si ritrova a fare i conti con la privazione e la precarietà, con uno stomaco perennemente vuoto ma con adulti presenti che, non avendo nulla che li distragga l’uno dall’altro, si ascoltano, si guardano, si parlano, partecipano l’uno alla vita dell’altro, sognando, sperando in una vita migliore.
Charlie, apparentemente più sfortunato dei vari Augustus e Veruca, cresce più forte, più resiliente degli altri, i quali senza il loro oggetto-feticcio vanno in crisi: la gomma, il cibo, la TV o il desiderio impazzito del tutto.
Charlie è un vincente perché, al contrario degli altri bambini, conosce l’amore.
Come aiutare i figli a realizzare se stessi: "Open" di Andre Agassi e "Indoor" di Mike Agassi
Per quanto riguarda l’educazione dei figli, una delle questioni che mi sta più a cuore è come possono i genitori aiutare i propri figli a raggiungere una adeguata e soddisfacente realizzazione affettiva e professionale.
Vorrei far partire le mie riflessioni dalle recenti vicende editoriali di Andre e Mark Agassi. Il primo, talentuoso tennista ritiratosi nel 2006, ha dato alle stampe nel 2009 il micidiale “Open. La mia storia”, in cui alla descrizione della sua sofferta carriera fa da sfondo una toccante descrizione dei suoi rapporti più significativi, tra i quali spicca quello con il padre-allenatore Mike. “Open” sembra la risposta al racconto autobiografico fornito dal padre Mike nel 2004 nel libro “The Agassi Story”, pubblicato nel 2015 per la prima volta in Italia – con degli aggiornamenti che fanno riferimento ad eventi accaduti dopo il 2004 – col titolo: “Indoor. La nostra storia”, ognuno dei quali rappresenta l’imprescindibile completamento alla narrazione dell’altro. Quello che si dipana in queste due autobiografie è un dialogo a tratti struggente tra padre e figlio i quali, pur non comprendendosi a vicenda del tutto, arrivano indirettamente a testimoniarsi il proprio affetto reciproco e dunque a tessere una sorta di riconciliazione. Il messaggio che ne ho tratto io da questa doppia narrazione è: “Non comprendo fino in fondo le tue ragioni e i tuoi sentimenti ma ti voglio bene per quello che sei e che hai fatto per me”.
Scrive Mike: “Quando nacque Andre, il 29 aprile del 1970, io ero pronto. Promisi a me stesso che non l’avrei stressato così come avevo fatto con Rita e Phillip. La mia intenzione era di cominciare a insegnargli i rudimenti del tennis prima che imparasse a camminare, a parlare, persino a sedersi. […] Avevo letto da qualche parte che il primo muscolo che un bambino sviluppa è quello che gli permette di puntare lo sguardo su qualcosa. Prima che il mio quarto figlio appena nato uscisse dal Sunrise Hospital di Las Vegas, progettai un attrezzo speciale per la sua culla: una palla da tennis che pendeva da una racchetta da tennis. E a casa, ogni volta che uno di noi passava davanti alla culla di Andre toccava la racchetta per far muovere la palla avanti e indietro; e ogni volta gli occhi di Andre – quegli occhi così grandi- seguivano la palla. La mia teoria era che per lui sarebbe diventato naturale, crescendo, vedere una palla da tennis che gli veniva incontro.”
Scrive in risposta Andre: “Ho sette anni e sto parlando da solo perché ho paura e perché sono l’unico che mi sta a sentire. Sussurro sottovoce: Lascia perdere, Andre, arrenditi. Posa la racchetta ed esci immediatamente da questo campo. Entra in casa e prenditi qualcosa di buono da mangiare. Gioca con Rita, Philly o Tami. Siediti vicino alla mamma che lavora a maglia o compone uno dei suoi puzzle. Non ti sembra bello? Non sarebbe magnifico Andre? Semplicemente lasciar perdere? Non giocare a tennis mai più? Ma non posso. Non solo mio padre mi rincorrerebbe per tutta la casa brandendo la mia racchetta, ma qualcosa nelle mie viscere, un qualche profondo muscolo invisibile me l’impedisce. Odio il tennis, lo odio con tutto il cuore, eppure continuo a giocare, continuo a palleggiare tutta la mattina, tutto il pomeriggio, perché non ho scelta. Per quanto voglia fermarmi, non ci riesco. Continuo a implorarmi di smettere e continuo a giocare, e questo divario, questo conflitto tra ciò che voglio e ciò che effettivamente faccio mi appare l’essenza della mia vita”.
Continua Mike: “Il mio libro è stato pubblicato nel 2004 e il lancio avvenne a New York durante gli US Open. Avevo bisogno di scriverlo per i miei figli, per dirgli com’era stato difficile arrivare fin dove sono loro adesso. Nel libro parlavo anche di quanto ero stato severo, nell’imporre loro una ferrea disciplina. Sì, probabilmente ho esagerato, ma chi lo sa davvero qual è il limite da superare e quale no?”
Che nome dare a questa commistione di atteggiamenti e sentimenti che assume le sembianze di un’ossessione di un padre per il successo del figlio? Quello di Mike è amore paterno potente e profondo, senza limiti e per questa ragione a tratti “autoreferenziale”.
Nel suo libro, Mike descrive i propri energici e caparbi tentativi di trasformare i suoi quattro figli in campioni del tennis. Quest’operazione diventa una sorta di missione di vita per lui, che si ritrova a diventare un padre-allenatore ossessivo, tirannico. Famosa la sua invenzione del “drago sparapalle” (macchina infernale che sparava a ripetizione palline da tennis alla velocità di 180 km l’ora) con cui costringeva suo figlio ad allenarsi nel giardino di casa. Leggendo le memorie di Mike, si scopre che egli aveva praticato pugilato in gioventù, ed era sempre stato un appassionato di tennis, sport elitario per eccellenza, sin da quando viveva in Iran e ricevette da bambino in dono da un soldato americano una racchetta di legno: quest’oggetto “mitico” divenne per lui, questa è l’impressione che ne ricavo accostandomi alla sua storia, un concentrato potente di desiderio di riscatto sociale e di volontà di raggiungere il Successo, anche attraverso i propri figli, spingendoli a raggiungere e superare i suoi limiti, chiedendo loro di fare ciò che lui non era riuscito a fare. Mike, più o meno consapevolmente, impone ai suoi figli il compito di realizzare il suo stesso sogno (infranto) di distinguersi nello sport (e in generale nella vita) sotto forma di “obbligo morale”. Colpisce la combattività di quest’uomo e la ferrea convinzione di aver stimolato i figli al raggiungimento di obiettivi sportivi molto alti (per tre di loro irraggiungibili) per il loro bene. Egli giunge a dare l’impressione di essere un padre “insaziabile”, quando spiega che Andre avrebbe potuto vincere di più, se solo avesse seguito di più i suoi consigli. L’imperativo categorico di quest’uomo è quello di arrivare al top, di combattere e vincere; egli non lo applica solo alla propria esistenza, ma cerca di trasmettere questo principio anche ai suoi figli per il loro bene.
Ma l’impressione del lettore è che lo faccia anche per il proprio benessere, per colmare, attraverso i figli, le proprie lacune, i propri progetti irrealizzati. L’impressione è che i figli Rita, Philip, Tami e Andre abbiano un ruolo riparativo nei confronti delle ferite di questo papà che, partito dal nulla (Mike è un armeno nato e cresciuto a Teheran in grande povertà ed emigrato negli Stati Uniti), è riuscito a realizzare una scalata sociale non comune (che conosce il suo culmine nella carriera sportiva di Andre). Ed è proprio questo lato della sua storia che ce lo rende meno “orco” e più umano, fragile. Nell’appendice del suo libro ringrazia i genitori “che hanno fatto il meglio che potevano con quello che avevano e che hanno visto i loro figli lasciare l’Iran uno dopo l’altro per un futuro migliore”. Ci sono lutti, perdite e separazioni nella storia di questa famiglia; ma anche speranza, sogni di gloria. La sua è stata una vita improntata all’inseguimento di un sogno: prima quello di emigrare, non a caso negli Stati Uniti, il paese per eccellenza dov’è possibile realizzare il proprio Sogno, poi di migliorare le proprie condizioni di vita con un lavoro dignitoso, una casa e infine una famiglia. Il tutto all’insegna del sacrificio e dello sforzo, dell’impegno, richiesti anche ai suoi figli. Mike alla fine si autoassolve: riflette sul fatto che lui avrà pure superato, nell’educazione dei figli, quel famoso limite che non dev’essere superato, ma il fatto che Andre sia benestante, famoso, generoso, che dia da mangiare a tutta la famiglia allargata, abbia una moglie e dei figli splendidi lo rassicura sul suo buon operato di padre.
Fa bene al rapporto genitori – figli il fatto che i genitori seguano a tal punto le attività sportive/scolastiche praticate dai figli, in generale i loro progetti di vita da arrivare a fare le veci di un allenatore, istitutore, professore? La risposta a mio parere è no. Il ruolo del genitore per essere svolto in modo adeguato necessita di un sano distacco. Il genitore dovrebbe essere per i figli una guida, dovrebbe guardarlo correre, non correre insieme a lui: se è ipercoinvolto, egli trasmette al figlio preoccupazione, ansia e un’implicita richiesta di essere tranquillizzato con una sua performance di successo. Il figlio si ritrova nella situazione di non sapere se impegnarsi in un progetto (che nel migliore dei casi è in sintonia anche con i propri desideri) per realizzare se stesso e le proprie aspirazioni o per far star bene qualcun altro (il proprio genitore), il quale tanto più eserciterà pressioni quanto più egli stesso non si sentirà realizzato. Sarà difficile per i figli sentirsi liberi di perseguire i propri progetti di vita quando accanto si hanno genitori così coinvolti da considerare propri i loro progetti di vita. Ma soprattutto sarà difficile prendere pienamente possesso della propria vita e imparare a fare le cose per se stessi, assumendosi le proprie responsabilità, quando si sente di doverle fare in primis per rendere felici genitori particolarmente richiestivi.
Riprendiamo il caso di Andre Agassi: sarà pur diventato ricco, famoso e filantropo generoso…. ma a quale prezzo? Quanta infelicità, quanti tentativi di lenirla anche attraverso sostanze stupefacenti, quanti auto sabotaggi, quante discese agli inferi e miracolose risalite, quanta insoddisfazione ha dovuto patire prima di riuscire a trovare un suo equilibrio interiore? A tale proposito, non credo che la serenità raggiunta in tarda età da Andre Agassi sia frutto della sua folgorante quanto travagliata carriera. Credo che c’entri molto l’amore per Stephanie Graff, anche lei figlia di un padre-allenatore quanto mai tiranno – come del resto la prima moglie di Andre, Brooke Shields (la cui madre le faceva da promoter e manager, vivendo sui suoi successi). Quanto devono essersi ritrovati e riconosciuti nelle loro ferite, compresi, consolati a vicenda?
Alessandro Baricco, commentando “Open”, scrive in “Una certa idea di mondo”: “Tutto sommato, l’unica cosa del libro che mi è spiaciuta è il finale. L’eroe si sposa, vince e scopre se stesso. Lieto fine, ma non è questo che mi è spiaciuto. È che l’eroe scopre il senso della vita iniziando ad occuparsi degli altri, i suoi figli innanzitutto, ma anche gli altri veri: apre una scuola per bambini, che non hanno la possibilità di studiare. Volontariato. Tutti felici. Sipario. È che io non ci credo. A me risulta che la ricerca del senso è una sorta di partita a scacchi, molto dura e solitaria, e che non la si vince alzandosi dalla scacchiera e andando di là a preparare il pranzo per tutti. È ovvio che occuparsi degli altri fa bene, ed è un gesto così dannatamente giusto, e anche inevitabile, necessario. Ma non mi è mai venuto da pensare che potesse c’entrare davvero con il senso della vita. Temo che il senso della vita sia estorcere la felicità a se stessi, tutto il resto è una forma di lusso dell’animo, o di miseria, dipende dai casi”. Forse a Baricco manca “la versione di Mike”. Letta quella, tutto è molto più chiaro: a me sembra che Andre non abbia iniziato a occuparsi degli altri (i figli, i bambini bisognosi) alla fine: tutta la sua carriera non è stato altro che un modo per occuparsi del papà, per prendersi cura di lui, dei suoi desideri, sogni, aspettative… Appagato (e curato) il papà, a fine carriera, è passato a occuparsi anche di altri.
La scoperta e la valorizzazione delle proprie risorse ne “Il mago di Oz” di Lyman Frank Baum
Il libro “The Wonderful Wizard of Oz” di L.F.Baum, pubblicato nel 1900, è una fiaba per giovanissimi e, come tutte le fiabe, è ricco di significati simbolici e può essere interpretato come viaggio iniziatico. Dorothy vive nel Kansas con lo zio Henry e la zia Emma in una piccola casa di legno.
Nel Kansas tutto è grigio: il terreno arato bruciato dal sole, le praterie inaridite, la casetta disseccata dal sole e lavata dalla pioggia, gli occhi e le gote della zia Emma, la lunga barba e gli stivali di cuoio dello zio Henry, che lavorando accanitamente da mattina a sera non sorride mai.
Ciò che impedisce anche a Dorothy di diventare grigia e seria come tutto ciò che la circonda è il cagnolino Totò, vivace cagnolino dagli occhietti scuri e il muso birichino.
Un giorno accade l’impossibile: un uragano scuote la casetta con tanta violenza da farla staccare da terra e farla atterrare molte miglia più in là, in uno strano mondo colorato di straordinaria bellezza. Se nel Kansas tutto è tetro e geometricamente squadrato, nel regno in cui il tornado scaraventa Dorothy tutto è sfavillante, come in un dipinto a olio, e dalle forme morbide e sinuose.
Su suggerimento della Strega del Nord, che le regala un paio di scarpette d’argento, Dorothy decide di andare nella Città degli Smeraldi a chiedere al Grande Mago di Oz un aiuto per tornare nel Kansas.
Inizia un viaggio fatto di una serie di avventure che faranno di una bambina annoiata e scontenta una ragazzina più consapevole delle proprie qualità e risorse personali e della bellezza delle piccole cose quotidiane (“Oh zietta cara! Se sapessi come sono felice di essere tornata a casa!” esclama Dorothy, alla fine della storia).
Dopo essersi incamminata alla volta del regno di Oz, Dorothy incontra i suoi futuri compagni di viaggio, lo Spaventapasseri, l’Uomo di latta e il Leone codardo i quali decidono di aggregarsi alla ragazza, ognuno con un desiderio da esprimere: lo Spaventapasseri vorrebbe un po’ di cervello, l’Uomo di latta un cuore e il Leone codardo il coraggio.
Aiutandosi a vicenda, condividendo esperienze che mai avrebbero immaginato, arrivano dal Mago di Oz che in realtà si rivela essere un gran ciarlatano dotato però di una grande dose di fantasia.
Ventriloquo, immigrato dal Kansas, giunto rocambolescamente nel suo futuro regno con una mongolfiera, riesce a farsi amare e rispettare dalla popolazione di quell’insolito mondo, che aveva evidentemente bisogno di essere governata da un leader carismatico. Oz rivela ai quattro protagonisti la sua identità, ma nonostante questo essi vogliono che lui li aiuti a realizzare i loro desideri.
Oz mette in luce come essi in realtà già possiedono ciò che cercano, altrimenti non sarebbero riusciti a giungere fino a lì, superando ogni sorta di avversità: lo Spaventapasseri, durante il viaggio, ha accumulato una gran quantità di esperienza che – spiega Oz – rende saggi e prudenti; l’Uomo di latta dimostra di avere sensibilità e generosità rare e il Leone codardo incute più terrore e rispetto di quanto non creda, il guaio è che gli manca la fiducia in se stesso.
Ma i tre continuano inutilmente a cercare delle soluzioni esterne alle loro insicurezze e il Mago li accontenta: riempie la testa dello Spaventapasseri di segatura e spilli (una mente acuminata); dona all’Uomo di latta un cuoricino d’argento (“un cuore nobilissimo”) che posiziona all’interno del petto; e fa bere una “magica” pozione verdognola al Leone, perché “il coraggio, uno ce l’ha di dentro, e quindi, fin tanto che non l’avrai bevuto, non si potrà chiamarlo così”. Rimasto solo il mago si sfoga tra sé e sé: “Ma come faccio a non comportarmi da ciarlatano quando tutta questa gente mi costringe a far cose che tutti sanno benissimo che non si possono fare?”. Dorothy, poi, possiede sin dall’inizio lo strumento per tornare a casa: le scarpette d’argento ricevute in dono dalla Strega del Nord, ma senza che ci sia la consapevolezza della loro funzione esse non valgono nulla. E solo alla fine del viaggio, un rito di passaggio da un mondo abitato da adulti un po’ distratti e lontani a un mondo in cui è lei la protagonista, Dorothy sarà cresciuta abbastanza per essere in grado di indossarle con consapevolezza e di ordinare, battendo tre volte i tacchi: “Portatemi a casa dalla zia Emma!”.
La scoperta e la valorizzazione delle proprie risorse ne “Il mago di Oz” di Lyman Frank Baum
Il libro “The Wonderful Wizard of Oz” di L.F.Baum, pubblicato nel 1900, è una fiaba per giovanissimi e, come tutte le fiabe, è ricco di significati simbolici e può essere interpretato come viaggio iniziatico. Dorothy vive nel Kansas con lo zio Henry e la zia Emma in una piccola casa di legno.
Nel Kansas tutto è grigio: il terreno arato bruciato dal sole, le praterie inaridite, la casetta disseccata dal sole e lavata dalla pioggia, gli occhi e le gote della zia Emma, la lunga barba e gli stivali di cuoio dello zio Henry, che lavorando accanitamente da mattina a sera non sorride mai.
Ciò che impedisce anche a Dorothy di diventare grigia e seria come tutto ciò che la circonda è il cagnolino Totò, vivace cagnolino dagli occhietti scuri e il muso birichino.
Un giorno accade l’impossibile: un uragano scuote la casetta con tanta violenza da farla staccare da terra e farla atterrare molte miglia più in là, in uno strano mondo colorato di straordinaria bellezza. Se nel Kansas tutto è tetro e geometricamente squadrato, nel regno in cui il tornado scaraventa Dorothy tutto è sfavillante, come in un dipinto a olio, e dalle forme morbide e sinuose.
Su suggerimento della Strega del Nord, che le regala un paio di scarpette d’argento, Dorothy decide di andare nella Città degli Smeraldi a chiedere al Grande Mago di Oz un aiuto per tornare nel Kansas.
Inizia un viaggio fatto di una serie di avventure che faranno di una bambina annoiata e scontenta una ragazzina più consapevole delle proprie qualità e risorse personali e della bellezza delle piccole cose quotidiane (“Oh zietta cara! Se sapessi come sono felice di essere tornata a casa!” esclama Dorothy, alla fine della storia).
Dopo essersi incamminata alla volta del regno di Oz, Dorothy incontra i suoi futuri compagni di viaggio, lo Spaventapasseri, l’Uomo di latta e il Leone codardo i quali decidono di aggregarsi alla ragazza, ognuno con un desiderio da esprimere: lo Spaventapasseri vorrebbe un po’ di cervello, l’Uomo di latta un cuore e il Leone codardo il coraggio.
Aiutandosi a vicenda, condividendo esperienze che mai avrebbero immaginato, arrivano dal Mago di Oz che in realtà si rivela essere un gran ciarlatano dotato però di una grande dose di fantasia.
Ventriloquo, immigrato dal Kansas, giunto rocambolescamente nel suo futuro regno con una mongolfiera, riesce a farsi amare e rispettare dalla popolazione di quell’insolito mondo, che aveva evidentemente bisogno di essere governata da un leader carismatico. Oz rivela ai quattro protagonisti la sua identità, ma nonostante questo essi vogliono che lui li aiuti a realizzare i loro desideri.
Oz mette in luce come essi in realtà già possiedono ciò che cercano, altrimenti non sarebbero riusciti a giungere fino a lì, superando ogni sorta di avversità: lo Spaventapasseri, durante il viaggio, ha accumulato una gran quantità di esperienza che – spiega Oz – rende saggi e prudenti; l’Uomo di latta dimostra di avere sensibilità e generosità rare e il Leone codardo incute più terrore e rispetto di quanto non creda, il guaio è che gli manca la fiducia in se stesso.
Ma i tre continuano inutilmente a cercare delle soluzioni esterne alle loro insicurezze e il Mago li accontenta: riempie la testa dello Spaventapasseri di segatura e spilli (una mente acuminata); dona all’Uomo di latta un cuoricino d’argento (“un cuore nobilissimo”) che posiziona all’interno del petto; e fa bere una “magica” pozione verdognola al Leone, perché “il coraggio, uno ce l’ha di dentro, e quindi, fin tanto che non l’avrai bevuto, non si potrà chiamarlo così”. Rimasto solo il mago si sfoga tra sé e sé: “Ma come faccio a non comportarmi da ciarlatano quando tutta questa gente mi costringe a far cose che tutti sanno benissimo che non si possono fare?”. Dorothy, poi, possiede sin dall’inizio lo strumento per tornare a casa: le scarpette d’argento ricevute in dono dalla Strega del Nord, ma senza che ci sia la consapevolezza della loro funzione esse non valgono nulla. E solo alla fine del viaggio, un rito di passaggio da un mondo abitato da adulti un po’ distratti e lontani a un mondo in cui è lei la protagonista, Dorothy sarà cresciuta abbastanza per essere in grado di indossarle con consapevolezza e di ordinare, battendo tre volte i tacchi: “Portatemi a casa dalla zia Emma!”.